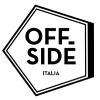“La partita è sospesa, il compagno Tito è morto”.
Se c’è un momento preciso, nel corso della storia, in cui si può individuare l’inizio della fine dell’esperienza jugoslava, quello è domenica 4 maggio 1980.
Allo stadio Poljud di Spalato si stava disputando l’incontro valido per il campionato nazionale fra Hajduk e Stella Rossa di Belgrado. Come sempre, quando si incontravano due formazioni di tale spessore la situazione si surriscaldava, essendo contrapposte due realtà che per quanto diverse erano molto vicine. Da una parte i dalmati, che rappresentavano una delle quattro squadre più seguite del Paese e riflettevano una forte identità geografica, ma anche di reazione e resistenza al potere costituito. L’Hajduk, personaggio storico della tradizione balcanica, mezzo brigante, mezzo Robin Hood, non aveva padroni e con eguale forza si scagliava contro chiunque volesse mettergli il giogo, fosse esso turco, austro-ungarico o, in qualche modo, anche jugoslavo.
Dall’altra parte la Stella Rossa, la squadra che doveva riprendere l’eredità delle grandi formazioni di Belgrado sciolte dopo la Seconda Guerra Mondiale. La squadra con la tifoseria più esigente, che non voleva solo vincere, ma anche vedere uno spettacolo. Il club tifato dagli intellettuali e dagli irregolari della Capitale, che solo qualche anno dopo sarebbe diventata la squadra dell’identità serba. In quel momento, su quel campo, rappresentava anche il potere costituito e come tale veniva osteggiata, a Spalato ma anche a Zagabria e in tutto il Paese, Belgrado compresa, lato Partizan ovviamente.
Al di là degli aspetti politici e di appartenenza la partita offriva anche spunti interessanti dal punto di vista tecnico. L’Hajduk era il campione in carica, mentre la Stella avrebbe vinto il campionato a fine stagione. Insomma una partita di cartello, come si dice in questi casi, e per questo trasmessa in diretta tv in una specie di posticipo ante litteram.
Stava per concludersi il primo tempo, quando tre uomini in abiti borghesi violando qualsiasi regola entrarono in campo e si diressero verso il direttore di gara. Bastarono poche parole e la giacchetta nera portò il fischietto alla bocca e decretò la fine della partita. Lo stadio fu pervaso dall’incredulità e dallo stupore. Toccò al presidente dell’Hajduk la responsabilità di informare tutti su ciò che era successo: “La partita è sospesa, il compagno Tito è morto”.
Non è facile guardare il filmato dell’epoca perché non è mai facile veder piangere delle persone adulte. Eppure quello che successe dopo quell’annuncio è davvero qualcosa che rimane impresso nella mente. Famosi giocatori abituati a enormi sforzi fisici e mentali che crollano sulle ginocchia, fotografi e addetti al campo che si commuovono e scoppiano in lacrime, mentre provano a portare a termine il loro lavoro. E il catino del Poljud in un silenzio irreale, dal quale emerge solo qualche rumore di pianti e lamenti. Poi succede qualcosa che visto con gli occhi di oggi appare come un inutile tentativo di stringersi per non aver paura. Un ultimo atto di resistenza prima che il piano inclinato della storia prenda velocità e travolga tutto. Un gesto istintivo e vacuo, profondo e ingenuo. Mentre i giocatori si erano schierati a testa bassa lungo la linea di centrocampo, senza più rispettare l’appartenenza alle squadre, tutto lo stadio intonò una canzone popolare, che diceva “Druže Tito mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo”, che tradotta suonerebbe più o meno come “Compagno Tito, te lo giuriamo, non ci allontaneremo mai dal tuo esempio”.
Con il senno del poi sappiamo come andarono a finire le cose e sappiamo come la Storia, quella con la S maiuscola, si allontanò dalle parole di quella canzone, cantata da tutti in un’ultima illusione di poter restare insieme.
Autore: Gianni Galleri