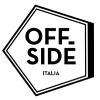di Fernando Martinho – Corner, #12
Traduzione di Alessandro Bai
Le premesse e le conseguenze politiche della più grande umiliazione della Seleção.
Nel dicembre 2011, Barcellona e Santos si affrontarono nella finale del Mondiale per Club FIFA. I campioni della Libertadores potevano contare tra le loro fila un 19enne Neymar e il 22enne Paulo Henrique Ganso. Per il Barça, quella partita rappresentava l’occasione per bissare il trionfo ottenuto due anni prima, quando a fatica i Blaugrana sconfissero ai supplementari l’Estudiantes di Alejandro Sabella.
Il risultato di quel match, tra la squadra che vantava i due giocatori più promettenti del calcio brasiliano – Neymar e Ganso, appunto – e un club affermato a livello mondiale, impreziosito dal giocatore più forte del globo, mostrò in modo spietato la distanza tra queste due realtà: 4-0.
Paulo Vinícius Coelho disse all’epoca, nei programmi ai quali partecipava, che nessuno poteva discutere la superiorità del Barcellona sul Santos, ma che allo stesso tempo quell’esito distorceva questa differenza.
Un anno prima, tuttavia, l’Internacional, campione della Libertadores, non raggiunse nemmeno la finale del Mondiale per Club. Dopo la sconfitta con i congolesi del Mazembe, in semifinale, avrebbe dovuto essersi acceso un campanello d’allarme, ma fu tutto ridotto a una sorta di incidente di percorso.
Allo stesso modo, anche il 4-0 rifilato dal Barça al Santos non servì a destare alcuna preoccupazione. La sensazione era la stessa, che ritornava puntualmente a ogni sconfitta contro le squadre europee. In questo caso, il tecnico Muricy Ramalho fu un codardo a schierare tre difensori, mentre Neymar si tirò indietro. C’era sempre una scusa buona.
Poi arrivò il 2012, anno della presunta redenzione del calcio brasiliano. I più conservatori si sentirono sollevati dalla vittoria per 1-0 del Corinthians sul Chelsea, che vinse la Champions League di quell’anno pur non essendo neanche lontanamente il migliore tra le quattro semifinaliste.
Tutto ciò non servì però a ridimensionare la gloria e i meriti del fortissimo Corinthians di Tite. Il resultadismo, metodo di frequente applicazione nella cultura brasiliana, fu evidente. Non si vuole dire che il risultato non importi: ovviamente importa, e molte volte è l’unica cosa che conta. Ma in questo caso, il risultatismo presuppone la lettura di una superiorità proprio a partire dal risultato stesso, tralasciando il modo in cui questo è stato ottenuto.
Tornando indietro di alcuni anni, nel Mondiale per club del 2006, lo stesso Internacional de Porto Alegre sconfitto quattro anni dopo dal Mazembe, piazzò uno dei maggiori exploit del calcio mondiale battendo il Barcellona di Ronaldinho, il miglior giocatore al mondo di quell’anno.
La stagione precedente, il São Paulo riuscì a battere il Liverpool che a propria volta, qualche mese prima, aveva sconfitto il Milan in quella finale epica giocata a Istanbul. Il miracolo, che permise ai Reds di pareggiare un match che stavano perdendo 3-0, questa volta riuscì alla squadra paulista, che conquistò il suo terzo titolo mondiale.
In entrambi i casi gli allenatori delle squadre brasiliane, Paulo Autuori e Abel Braga, adottarono una strategia simile, in sostanza facendo ciò che potevano per affrontare un avversario superiore. La spiegazione della superiorità era economica, e questo vantaggio finanziario ha continuato ad aumentare, creando così una discrepanza nel paragone tra le qualità delle rose migliori d’Europa e del Sud America.
Fino al 2000, quando il Boca Juniors divenne campione mondiale superando il Real Madrid di Figo, il giocatore più forte al mondo dell’epoca, non c’era differenza tra le più grandi del Vecchio Continente e quelle sudamericane. La Legge Bosman, resa possibile grazie al Mercato comune europeo che si stava formando, e la moneta unica adottata in questo nuovo blocco economico furono i fattori che, anni dopo, finirono per riflettersi sul rettangolo verde, diventando evidenti in occasione del Mondiale per Club organizzato dalla FIFA dal 2005, in sostituzione della Coppa Intercontinentale.
La possibilità economica e burocratica di mettere sotto contratto giocatori di diverse nazionalità diede modo a una cerchia di club europei di prevalere sui propri rivali continentali e sugli avversari dell’altro lato dell’Oceano Atlantico.
Iniziarono a sorgere superpotenze come Bayern, Manchester United, Milan, Inter, Barcellona e Real Madrid che, come mai prima, concentrando i migliori giocatori al mondo, nel rispetto della nuova legislazione in vigore che non conteggiava i giocatori nati in altri paesi dello stesso continente come stranieri. A questo si somma il fatto che molti atleti sudamericani possiedono passaporti europei per via delle proprie discendenze familiari o per la permanenza in un paese nel quale hanno esercitato la propria professione.
Questi club, destinati a diventare sempre più grandi e forti, formavano una vera e propria Torre di Babele. Nel 2010, l’Inter salì sul tetto d’Europa senza contare nemmeno un italiano tra i titolari e soltanto tre includendo anche le riserve. Uno di loro era Mario Balotelli.
Il Barcellona del 2011 rappresentò un caso a parte, poiché il lavoro di Pep Guardiola fu molto efficace nel creare una rosa con giocatori cresciuti in casa, alcuni dei quali lasciarono il club da molto giovani prima di rientrare alla base, come Gerard Piqué e Cesc Fabregas. Persino la stella più grande, Lionel Messi, fu cresciuto dalla squadra catalana, pur essendo argentino.
A partire dall’inizio del nuovo millennio la maggior parte dei campioni d’Europa, per ragioni economiche e logiche di mercato, cominciò a puntare su rose multinazionali. Fondata nel 1992, la Premier League cominciava in questi anni a mostrare un grande potenziale economico grazie alle entrate garantite dal mercato asiatico, e il Manchester United fu pioniere su questo fronte, seguito poi a ruota dal Real Madrid, come spiegato da Ferran Soriano nel libro “La palla non entra per caso”.
Questo mercato riscaldato diventò attraente per i migliori calciatori provenienti da ogni angolo del mondo, soprattutto dal Brasile e dall’Argentina. I contratti milionari, uniti alla qualità di vita europea, erano troppo seduttori – il dislivello degli anni successivi era una conseguenza inevitabile.
Pep Guardiola rimase al Barcellona fino al maggio del 2012, sei mesi dopo aver inflitto al Santos quel sonoro 4-0. L’allora miglior tecnico del mondo lasciava orfani i Blaugrana e, dopo un anno sabbatico, decise di accasarsi al Bayern Monaco, che era reduce dalle vittorie in Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania. Guardiola arrivò in un club vincente per natura, con una rosa di livello e un calcio esuberante – spettava al nuovo allenatore perfezionare la squadra lasciata in eredità da Jupp Heynckes, ma l’asticella era alta.
Fu nel 2013 che un altro incidente si verificò nuovamente al Mondiale per Club. Il rappresentante del Sud America, l’Atlético Mineiro, fu sconfitto dal Raja Casablanca e non arrivò a confrontarsi in finale col Bayern di Guardiola. Il “Galo” non poteva più contare su Bernard, un personaggio centrale nello sviluppo di questo testo. Il giovane centrocampista offensivo era stato venduto allo Shakhtar Donetsk subito dopo la conquista della Libertadores.
Il lavoro di Guardiola al Bayern da un lato e il modo in cui Bernard veniva considerato dall’opinione pubblica brasiliana spiegano in gran parte ciò che si leggerà in seguito. L’altro aspetto, invece, ha a che fare con la Confederations Cup.
Bernard era in procinto di compiere 21 anni quando si trasferì allo Shakhtar, in un 2013 magico per quel giovane promettente. Le sue prestazioni all’Atlético Mineiro gli valsero una convocazione per la Seleção, che quell’anno era chiamata a disputare la Confederations Cup proprio in Brasile, un anno prima della Coppa del Mondo che sarebbe stata giocata in casa.

Dopo essersi aggiudicata le principali competizioni giocate tra il 2008 e il 2012 – tra queste non consideriamo la Confederations Cup 2009, semplicemente perché non si tratta di un torneo di primaria importanza – la Spagna arrivava in Brasile come logica favorita, considerati il Mondiale e i due Europei vinti in quattro anni. Tuttavia, come già detto, la competizione era ben lungi dal rappresentare una priorità per le grandi nazionali europee.
Durante la fase a gironi, giocata a ritmo di allenamento, la Spagna rifilò una goleada storica a Tahiti in un Maracanã totalmente rinnovato, inaugurato proprio poco prima della Confederations Cup. Il risultato rispecchiava la forza dei “campioni di tutto”. Le “Furie Rosse” di quei tempi contavano ben nove giocatori provenienti da quel Barcellona che umiliò il Santos nel 2011: Valdés, Piqué, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Fàbregas, Pedro e David Villa.
In quel tardo pomeriggio invernale, a Rio de Janeiro ci fu la più grande manifestazione popolare dell’epoca, che rimase scolpita nella storia della politica nazionale. I bersagli della protesta erano Dilma Rousseff, Sérgio Cabral e Eduardo Paes, e la PEC36 – che prevedeva uno snellimento delle leggi sul lavoro, oltre a degli aumenti delle tariffe dei trasporti pubblici – era la ragione che spinse i partiti di sinistra a mobilitarsi in modo massivo nella città che avrebbe ospitato la finale di quel torneo e della Coppa del Mondo dell’anno successivo.
Il Brasile superò agevolmente la fase a gruppi e in semifinale affrontò il suo avversario più duro, campione dell’ultima edizione della Copa America: l’Uruguay. In particolare, fu un episodio a richiamare l’attenzione: l’inno nazionale che la torcida e i giocatori proseguirono a cantare a cappella, vista l’esecuzione di una versione abbreviata scelta in occasione dell’evento. Il nuovo Mineirão, ricolmo e tinto di verde-oro, urlava in modo impetuoso in una dimostrazione esacerbata di nazionalismo che conteneva simbolismi pericolosi. Era solo l’inizio di un sentimento che sarebbe cresciuto.
La partita, durissima, finì con la vittoria brasiliana sull’Uruguay per 2-1, nello stadio appena inaugurato nel quale, un mese dopo, l’Atlético Mineiro di Bernard sarebbe stato incoronato campione continentale. Sembrava essere uno stadio destinato a vivere glorie indimenticabili.
Il trionfo sull’Uruguay riempì di orgoglio un Paese che attraversava un momento di fortissima speculazione immobiliare, un’inflazione crescente che toglieva capacità di spesa alle classi più basse, tutto frutto di una politica poggiata sul potere di acquisto dei livelli più sfavoriti, con prestiti che spuntavano da tutte le parti, in una specie di miracolo economico alla brasiliana, promosso dal Partito dei Lavoratori. Era l’inizio della fine di un modello che offrì alla classe media opportunità mai viste, e le domande di questa stessa classe media non sarebbero mai più state le stesse.
Se nel Mineirão l’inno a cappella attirò l’attenzione, nella finale contro la Spagna, campione mondiale tre anni prima e reduce dalla doppietta europea, l’eco fu ancora più grande. La manifestazione nazionalista fu visibile nei giocatori e nei tifosi una volta che, di nuovo, il cerimoniale della FIFA abbreviò l’esecuzione della prima parte dell’inno. I calciatori abbracciati e la torcida, in coro, terminarono la parte mancante con gli occhi lucidi. In precedenza, durante l’inno spagnolo, qualche fischio e giocatori in silenzio – non si trattava di mancanza di nazionalismo, semplicemente l’inno spagnolo non ha un testo.
Peraltro, il nazionalismo spagnolo merita un capitolo a parte: una foto successiva alla conquista dell’Europeo mostrava tutti i giocatori del Barcellona e di quella nazionale in posa dietro il trofeo appena vinto, mentre Juanfran, giocatore dell’Atletico Madrid, camminava dando le spalle. Normale che i calciatori di uno stesso club festeggino insieme dopo una vittoria, tuttavia, Xavi era avvolto nella bandiera – non separatista – della Catalogna. Oltre a lui, Fabregas, Piqué, Busquets, Jordi Alba e Vitor Valdés erano catalani, mentre Iniesta e Pedro sono oriundi di Castilla-La Mancha e delle Isole Canarie. L’integrità nazionale spagnola è sempre messa in discussione dai nazionalismi, indipendentismi e separatismi delle varie regioni del territorio iberico, mentre in Brasile, a dispetto di qualche movimento pseudo-separatista nel Rio Grande do Sul e delle dimensioni continentali del Paese, il sentimento di unità è molto più forte e questo viene rappresentato in forma singolare proprio attraverso la maglia gialla della Seleção.
Simbolo nazionale, sinonimo di un orgoglio che scarseggia in altri ambiti, la maglia del Brasile sarebbe stata protagonista politica a partire da quel momento. Quel gioco contro la Spagna segnò un prima e un dopo nella storia del Paese. La sensazione di aver conquistato il titolo di campione del mondo battendo una squadra che aveva vinto tutto fino a quel punto, non solo condannò i ragazzi di Luiz Felipe Scolari al peggior umiliazione della storia del calcio brasiliano, ma determinò anche la direzione politica della nazione.
Quel Barcellona e quella Spagna che vinsero e convinsero il mondo con un calcio rivoluzionario, erano già diventati obsoleti, senza che nessuno se ne accorgesse. Il ritmo di allenamento al quale andarono le “Furie Rosse” in quella Confederations Cup, dimostrava in modo nitido che non c’era più futuro per il tiki-taka nella forma che avevamo conosciuto tra il 2008 e il 2012.
Con questi stessi giocatori, e senza Messi infortunato, il Barcellona era stato distrutto dal Bayern di Jupp Heynckes in semifinale di Champions League, con il risultato complessivo di 7-0. Tutto questo accadde due mesi prima della scampagnata del Brasile sulla Spagna al Maracanã. Sia nell’incrocio tra i tedeschi e Barça, che nella finale di Confederations Cup, scesero in campo Piqué, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta e Pedro.
Il risultatismo in questione è sintomo di una cultura. L’idea che battere i campioni in carica trasformi il vincitore del duello in campione – come accade nella boxe – poggia su un assunto riduzionista pericoloso. Indubbiamente nessuno entra in campo per perdere, ma il contesto va preso in considerazione e, soprattutto, la comprensione della posta in palio. Normalmente, le due fazioni competono per lo stesso obiettivo, ma è molto comune che ci sia una differenza di ambizione, e l’esempio lampante è dato dall’eterno dibattito sull’importanza data dagli europei alla Coppa Intercontinentale.
Un altro esempio, era la Confederations Cup. Includendo tutti i campioni continentali, il torneo simulava alcuni aspetti di un mondiale, senza però replicarne l’importanza. Ma il Brasile era il Paese che prendeva più sul serio la competizione – l’unico paragone possibile è quello con il Mundialito disputato in Uruguay tra il 30 dicembre 1980 e il 10 gennaio 1981, nel quale gli uruguagi ebbero la chance quasi unica di sentirsi di nuovo campioni del mondo, a 30 anni di distanza.
Il Brasile prendeva tanto sul serio la Confederations Cup che, nel 2001, dopo il rendimento deludente di una Seleção privata di tutti i suoi migliori giocatori, il tecnico dell’epoca, Emerson Leão, fu esonerato, come se il test event della FIFA avesse anche una grande valenza sportiva.
2005, 2009 e 2013. Il Brasile conquistò le tre Confederations Cup per poi deludere nei Mondiali seguenti, con alte aspettative accompagnate da poco calcio. Ovviamente, le attese erano misurate in base alle prestazioni e alle vittorie ottenute l’anno prima, in un torneo nel quale gli avversari entravano in campo con ambizioni di gran lunga minori a quelle brasiliane. Così, quando arrivava la Coppa del Mondo, la prospettiva cambiava, e l’asticella si faceva molto più alta.
Arrivò quindi il 2014 e la squadra di Luiz Felipe Scolari toccò con mano il nazionalismo sugli spalti. Quel profilo di tifoso, già visto durante la Confederations Cup negli stadi appena realizzati, era strettamente legato al cambiamento sociale che il Brasile aveva attraversato nei 10 anni precedenti. Un’ascensione economica di una parte considerevole della popolazione, basata soprattutto sul consumo, in procinto di vivere però l’ultimo anno di questa illusione. Era anche anno di elezioni e la maglia amarela uscì dalle tribune per conquistare anche le strade.
A differenza del 2013, quando le manifestazioni ebbero un nucleo chiaramente partitista e popolare che guadagnò il sostegno della classe media, a partire dal 2014 il colore delle magliette della Seleção cominciò a invadere le passeggiate in riva al mare a Rio de Janeiro e l’Avenida Paulista a São Paulo, specialmente di domenica, caratterizzando i momenti di svago familiare e non le minacce di sciopero di operai e lavoratori, come accaduto nel 2013.
Le urla costanti “non ci sarà la Coppa” e le folle viste nel 2013 persero forza con l’arrivo del 2014 e furono facilmente represse dalle forze di polizia militare. Le leadership politiche di sinistra fecero saltare il governo, portando il Paese più a sinistra di quanto già fosse, nonostante le sue agende chiaramente neoliberiste, con il fomento al consumo e al benessere sociale. Banche, appaltatori e grande imprese lucrarono come mai nel periodo del periodo del Partito dei lavoratori (PT). Il terreno era preparato a un discorso patriottico: bastava che l’allora imminente crisi economica facesse sentire i suoi effetti toccando il portafoglio della classe media per far sì che il Brasile vedesse anche l’altra faccia della medaglia.
L’altra crisi, quella calcistica, sarebbe esplosa nella semifinale, con l’emblematico 7-1. Tutti si ricordano della partita e del “è diventata una passeggiata” di Galvão Bueno. Una batosta senza precedenti nella storia della Seleção. Una squadra squilibrata molto più psicologicamente che a livello tattico o tecnico. E l’inno nazionale ha a che fare con tutto questo.
Neymar era stato fatto fuori dalla dura entrata di Camilo Zúñiga nei quarti di finale contro la Colombia, dove l’avversario colpì col ginocchio una vertebra della regione lombare del miglior giocatore brasiliano. Era un brutto colpo, ma a giudicare dalla reazione dei brasiliani e soprattutto della commissione tecnica della CBF, il disastro era molto più legato al nazionalismo che all’assenza di Neymar, o alla qualità degli altri giocatori.
Quando il Brasile fu eliminato dal Mondiale tedesco del 2006 per mano della Francia, divenne opinione comune il fatto che l’allenatore dell’epoca, Carlos Alberto Parreira, avrebbe dovuto chiedere al volante Gilberto Silva di restare incollato a Zidane, autore di una delle sue migliori prestazioni individuali. La verità è che se ci fossero stati due centrocampisti appiccicati a lui Zidane li avrebbe umiliati entrambi.

Nel 2010, dopo l’errore di Julio Cesar in occasione dell’autogol di Felipe Melo, che oltre a deviare il pallone nella propria rete fu espulso, i colpevoli furono trovati facilmente. Tuttavia, a pagare fu il tecnico Dunga: aveva perso, quindi non ci sapeva fare. Eppure, nel 2009 sembrava essere l’uomo giusto, dato che nonostante un atteggiamento antipatico il lavoro era positivo, non solo per i risultati, ma soprattutto per la capacità di mettere insieme una squadra competitiva senza le stelle di un tempo, e con i pochi craque a disposizione, come Kakà, sulla via del declino fisico.
Nel 2014, il giornalista André Rizek chiese a Felipão di essere coraggioso e di non optare per una strategia difensiva nonostante l’assenza di Neymar. Scolari decise così che Bernard, quel giovane giocatore campione della Libertadores con l’Atlético Mineiro nel 2013, sarebbe stato il prescelto per prendere il posto del numero 10. Molto bene.
Thiago Silva, sorpreso a piangere durante la serie di rigori avvenuta contro il Cile nello stesso Mineirão, era l’altro grande assente brasiliano in quel match contro la Germania. Il pianto del difensore non era altro che un sintomo del nazionalismo in questione. Era un sentimento che straripava, difficile da controllare per i giocatori.
L’ufanismo (espressione che indica la tendenza brasiliana a considerarsi superiori in virtù delle vaste dimensioni del Paese e della sua ricchezza a livello naturale, N.d.T.) impedì al popolo e alla commissione tecnica di vedere che Dante, difensore del Bayern Monaco, era inadatto a giocare al fianco di David Luiz. José Mourinho aveva già mandato un segnale, scegliendo di non schierare David Luiz nella difesa del Chelsea nella stagione precedente al Mondiale 2014. Quando Mourinho decideva di farlo giocare, il calciatore veniva schierato a centrocampo.
La sconfitta per 7-1 ha molto meno a che vedere col calcio di quanto si immagini. Il risultato fu tanto umiliante da lasciare tutti disorientati, innescando la ricerca di una spiegazione tattica e un’ammirazione verso lo splendido lavoro fatto dalla Germania, ingiustificata però se si prendono in considerazione i risultati tedeschi precedenti e successivi a quella Coppa del Mondo disputata in Brasile.
Il 7-1 è molto più collegato alla cultura brasiliana e questo si riflette sul calcio giocato e sul modo di vedere il mondo. Schierare Bernard al posto di Neymar è risultato di ingenuità o di prepotenza, dato che queste due cose possono confondersi tra loro. La prepotenza posta con sé una visione ingenua del mondo, ed è un qualcosa che nacque dal Mondiale del 2002, quello che regalò alla Seleção la quinta stella. È un’arroganza che deriva dall’orgoglio nazionale provato nell’essere l’unico Paese ad aver vinto cinque volte la Coppa del Mondo. Nel 2002, Italia e Germania erano a quattro titoli mondiali – queste due squadre, furono vice-campioni in occasione delle ultime due vittorie brasiliane, un fatto che alimentava in modo ancor più forte quella sensazione che nessuno sarebbe mai stato capace di superare “o País do Futebol” (“il Paese del calcio”, N.d.T.).
Tornando alla partita: erano in campo per la Germania Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Toni Kroos e Thomas Müller, tutti giocatori del Bayern a quel tempo, la stessa squadra che passeggiò sul Barcellona di Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta e compagnia. Il Brasile non aveva poi così tante ragioni per sentirsi forte, a maggior ragione dopo che la Spagna, battuta dalla Seleção nel 2013, era stata umiliata con un 5-1 dall’Olanda nella fase a gruppi, che le “Furie Rosse” non avrebbero poi nemmeno superato.
Il lavoro del Bayern Monaco, quello sì, mostrava una grande continuità ed era servito a costruire una base di giocatori tedeschi poi diventati la spina dorsale della nazionale tedesca. Tuttavia, guardando una ad una alle prestazioni della Germania nel Mondiale 2014, è chiaro che il risultato ottenuto con il Brasile fu un’anomalia e incompatibile con il calcio offerto fino a quel momento.
Al debutto, contro un Portogallo mal assortito e privo del suo miglior giocatore, Cristiano Ronaldo, il 4-0 finale diede a posteriori l’impressione che, considerando anche il 7-1, la Germania avesse giocato un torneo perfetto. Ma non è così, e per capirlo basta guardare la seconda partita.
A Fortaleza, la Germania ebbe grandi difficoltà contro il Ghana: dopo aver segnato l’1-0 con un ginocchio-testa di Mario Götze, gli avversari ribaltarono la partita e quasi rischiarono di vincere, se non fosse stato per l’opportunismo di Miroslav Klose, cruciale per evitare una sconfitta. Indubbiamente, quella africana era una squadra molto competitiva che, tuttavia, non riuscì neanche a qualificarsi per gli ottavi di finale.
Nella terza partita del girone, una vittoria semplice avrebbe garantito la qualificazione, ma dall’altra parte c’erano gli Stati Uniti, allenati da Jürgen Klinsmann, storico goleador tedesco e ex-tecnico della nazionale proprio nel Mondiale 2006. La Germania incontrò nuovamente grandi difficoltà e riuscì a vincere 1-0 grazie all’implacabile Thomas Müller. Dopo il primo e unico gol, la gara si raffreddò in virtù del risultato che garantiva a entrambe le squadre il pass per gli ottavi, richiamando un episodio della Coppa del Mondo del 1982, quando sempre dopo l’1-0 il match tra tedeschi e austriaci si trasformò in una partitella tra amici, con quel parziale sufficiente a spedire le due nazionali alla fase successiva.
La fase iniziale disputata dalla Germania fu tutt’altro che impeccabile: nessuno li considerava come grandi candidati al titolo fino a quel punto, tolto quel tradizionale favoritismo attribuito a una qualsiasi nazionale che abbia già vinto almeno un Mondiale. Negli ottavi, l’Algeria non sembrava essere un grande ostacolo per la cavalcata tedesca, ma lo fu eccome: la Germania ebbe bisogno dei supplementari per sbloccare il risultato a Porto Alegre. Con un gollonzo di Schürrle in seguito a un cross arrivò l’1-0 della Mannschaft, mentre Mesut Özil raddoppiò nel secondo tempo supplementare. Gli algerini riuscirono addirittura ad accorciare le distanze, ma nonostante un po’ di sofferenza la Germania centrò la qualificazione.
Arrivarono poi i quarti di finali, nella tipica giornata calda di pieno inverno carioca. La Francia era una squadra in costruzione, un progetto che sarebbe sfociato nel secondo posto all’Europeo 2016 e nella vittoria del Mondiale 2018. La partita fu dura, il gioco bloccato e particolarmente lento a causa degli oltre 31 gradi registrati al Maracanã quel pomeriggio. Con una prestazione solida, grazie anche al gol precoce di Matt Hummels nato da una punizione di Toni Kroos, la Germania raggiunse la semifinale nella quale avrebbe incontrato il Brasile, cinque volte campione del mondo e padrone di casa della competizione.
Dopo aver sconfitto la Colombia in un match molto combattuto, l’euforia nazionalista s’impossessò quasi di tutti. La semifinale si trasformò così in un duello tra adulti e bambini. L’emozione dei giocatori durante l’esecuzione dell’inno nazionale, di nuovo cantato a cappella, e la maglietta di Neymar esibita da David Luiz e Júlio César, misero però in evidenza quanto questi simboli nazionalisti contino poco o niente quando a dover parlare è il campo. Quell’episodio è la dimostrazione di quella massima che afferma che se cantare l’inno nazionale con entusiasmo portasse qualche risultato, allora il Messico avrebbe almeno 10 Coppe del Mondo.
In verità, si trattò solo di un’enorme dimostrazione di squilibrio per una fase così avanzata di una competizione nella quale la concentrazione fa così tanta differenza. In questo aspetto, i tedeschi dimostrarono di saper rimanere focalizzati sull’obiettivo anche a risultato già acquisito. Con il tabellino che segnava 5-0, non tirarono indietro il piede ma non tentarono neanche di umiliare l’ubriacone già caduto a terra. Il risultato finale, 7-1, mostrò una superiorità emozionale maiuscola, e solo guardandolo fu possibile rendersi conto del risultatismo che distorse tutto ciò che ci fu prima e dopo quella partita.

Non ci fu in questo caso né il calcio totale olandese né un tiki-taka innovatore. In campo c’era un blocco importante del Bayern, già allenato da Guardiola, che mostrava un certo tipo di calcio. Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Toni Kroos e Thomas Müller, tutti protagonisti del 7-1, promuovevano infatti lo stesso stile di gioco del proprio club, che sembrava quasi meccanico, senza margine di errore tattico e con una dimostrazione tecnica e fisica impeccabile. Vale però la pena ricordare che questo stesso Bayern di Guardiola non era riuscito a superare il Real Madrid in Champions League due mesi prima. C’erano già altri modi di vincere nel calcio.
In finale, una partita preparata nei dettagli da entrambe le parti, se non fosse stato per gli errori di Gonzalo Higuaín, Rodrigo Palacio e Martín Demichelis il titolo del 2014 sarebbe finito in altre mani, a riprova del fatto che non c’era nulla di straordinario nella nazionale tedesca. Tuttavia, si impose da lì una narrativa basata in modo equivoco sul 7-1: una partita al quale ridurre un’intera competizione, sicuramente non giocata male, ma ben distante da quel progetto sportivo perfetto che fu descritto dopo la conquista del Mondiale.
A confronto, il percorso della Francia a Russia 2018 fu molto più stabile e incisivo, ma senza una vittoria tanto roboante in molti finirono per descrivere una nazionale quasi poco brillante. Tuttavia, il calcio giocato dai francesi fu napoleonico, non c’era modo di batterli. La Germania, invece, deve molto a Higuaín, ma non solo. La mancata finalizzazione di Palacio dopo un cross di Marcos Rojo mise a nudo i buchi di una difesa non impenetrabile. Alla fine, però. l’errore di Demichelis lasciò Mario Götze totalmente libero di segnare il gol del trionfo, già nei supplementari. L’Argentina diede prova di forza tattica e, soprattutto, psicologica in quella Coppa del Mondo, ma la “straordinaria” Germania ebbe ancora bisogno dell’extra-time per vincere.
Ciò che rimase, togliendo tutte le esagerazioni dell’opinione pubblica, fu una Germania forte, con giocatori capaci di rimanere sufficientemente freddi per disputare 90 o 120 minuti di livello in una competizione di breve durata. Gente come Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos e Mesut Özil controllava il gioco: tutto passava da loro, un centrocampo indubbiamente di altissimo livello. Per non parlare di Thomas Müller, calciatore polivalente, senza una posizione definita, un attaccante che marca e un incursore capace di segnare come un numero 9. Di quella squadra facevano parte però anche Höwedes e Mustafi, giocatori mediocri in mezzo ad altri fortissimi.
Tutto però fu ridotto al 7-1 e l’autostima del Brasile ne uscì profondamente ferita. Il calcio, da sempre simbolo di orgoglio nella cultura brasiliana, andò oltre il rettangolo verde e fuori dagli stadi. La maglia verde-oro della Seleção cominciò a far parte di una serie di manifestazioni a partire da quel momento. Infuriati per la sconfitta nelle elezioni di fine 2014, che concesse a Dilma Rousseff e il suo pessimo governo un altro mandato, l’opposizione e i suoi elettori iniziarono a promuovere sfilate con furgoni, megafoni, pupazzi gonfiabili, e l’immancabile maglia del Brasile.
Il governo di Dilma è raffigurato dagli stessi indici economici: inflazione e inadempienza allarmanti e un mercato impaurito dalla fine delle linee di credito. Il pessimismo si instaurò e il 2015 divenne il palco per le manifestazioni “soprapartitiche” che paragonavano il governo PT a una dittatura socialista e disseminavano la fantasia di un comunismo imminente. Da Lula fino a Dilma, i governi ebbero gravi difetti, ma non assomigliarono mai a una dittatura e non ebbero nulla di socialista. Al contrario, c’era molta economia di mercato e delle libertà che nessuna dittatura avrebbe mai tollerato.
Come simbolo di un nazionalismo residuo dai tempi del regime militare, la maglia verde-oro è stata usata per manifestare l’opposizione a questo presunto socialismo finanziato da allucinazioni che, a propria volta, erano un lascito dei tempi della Guerra Fredda.
Cuba, la Corea del Nord e il Bhutan – unici Paesi con un regime comunista – riescono a malapena ad autofinanziarsi, figuriamoci ad appoggiare un altro governo. Il Venezuela, con la sua economia precaria e caotica, è diventato una minaccia paragonabile all’Unione Sovietica all’auge delle tensioni politiche tra capitalismo e socialismo. L’immaginario popolare ha abbracciato queste allucinazioni non soltanto per via della delusione data dalla Seleção sul campo, ma a causa delle spese riservate agli stadi di calcio in un Paese che presenta una carenza di ospedali e scuole. Il sentimento ingenuo di chi tifa è lo stesso di chi vota. L’impeachment (di Dilma Rousseff, N.d.T.) è avvenuto in questo contesto, per niente ragionevole e molto “ufanista”. Sono affiorati dei valori conservatori alla fine di un socialismo che intendeva instaurare un’educazione sessuale che, secondo queste forze pseudo intellettuali di destra, era mirata a trasformare tutti i bambini in omosessuali. Falsità molto simili a quelle degli Anni 60 e 70, nei quali si affermava che i comunisti mangiavano i bambini.
Il risultato è l’unica cosa che importa, in questo risultatismo culturale. Non contava se il governo PT fosse stato veramente neoliberale, contava gridare l’inno durante il congresso nazionale dopo l’impeachment, una sorta di rivincita morale dal 7-1, e pulirsi la coscienza al Maracanã dopo la medaglia d’oro ottenuta alle Olimpiadi con gol decisivo di Neymar nella serie di rigori proprio contro la Germania, ma con Michel Temer come presidente della repubblica.
Niente di meglio che il calcio per spiegare come funzionava la corruzione. Gli sperperi avvenuti con gli stadi della Coppa del Mondo 2014 sono stati talmente evidenti che l’immaginario popolare si è sentito derubato. Dopo l’impeachment, mancava poco alle elezioni del 2018: il candidato che avrebbe vestito la maglia verde-oro della Seleção, dando voce a quel patriottismo che si era visto sulle tribune, promettendo un Paese simile a quello campione del mondo nel 1970, in tempi di regime militare e di caccia al fantasma del comunismo, avrebbe ottenuto l’adesione immediata di una grande parte di popolazione. É esattamente ciò che è successo. La maglietta amarela ha vinto, il Brasile no.
Si ringraziano l’autore Fernando Martinho e la rivista Corner per la cortesia e la disponibilità.