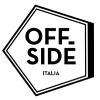di Andrés Burgo – elDiarioar.com, 26/6/2021
Traduzione di Andrea Meccia
In seguito alla storica sconfitta contro il Belgrano, il River scendeva in seconda divisione, corollario di tre anni di sfacelo istituzionale e sportivo. Quel giorno, nonostante tutto, segnò il primo passo della risurrezione del club che passerà dal dolore più profondo ai suoi anni più felici.
Come accade nelle fiction, anche nel calcio ci si rimpicciolisce di fronte alla realtà, e dieci anni fa, il 26 giugno 2011, accadde l’impossibile: il River Plate andava in Serie B. Il club che appariva indistruttibile andò in pezzi dopo tre stagioni e 116 partite a causa di un processo di autodistruzione, che portò prima ad una retrocessione di tipo istituzionale – dirigenziale ed economica – e successivamente ad una di tipo sportivo, rappresentata da una squadra in stato zombi.
Il pareggio per 1-1 contro il Belgrano allo stadio Monumental, inutile per ribaltare il vantaggio che la squadra di Córdoba aveva ottenuto nella gara di andata, unì nel rancore milioni di argentini che, a loro volta – nell’ennesimo esempio di quanto lo sport sia una fabbrica di successi inimmaginabili – non riconoscevano in quella caduta l’incubazione di un fenomeno inverso, quello della rinascita.
Nel decennio successivo, il River sarebbe tornato ad essere il River (forse ancor più forte) e avrebbe raggiunto la cima del suo Everest, il Superclásico che decise la Copa Libertadores 2018. Per la gran maggioranza dei suoi tifosi, la B rimase relegata all’insopportabile primo tempo di una lunga partita che il River avrebbe chiuso con una vittoria.
La caduta
Santiago Gallucci Otero è stato un testimone diretto della retrocessione: nel pomeriggio del 26 giugno 2011 era seduto per la prima – e in realtà anche l’ultima – volta sulla panchina del River durante una partita ufficiale. Al centrocampista, attualmente in forza al San Martín de Tucumán, era toccato aggregarsi alla prima squadra nel peggior momento possibile. «Arrivai in squadra dall’Under 14, poi giocai in tutte le categorie delle giovanili e nel 2010 fui sparring dell’Argentina al Mondiale», racconta a elDiarioAR da Tucumán. «L’allenatore Juan José López mi chiamò per entrare in prima squadra a sei o sette giornate prima del finale di stagione. Essendo noi il River, non pensavamo che saremmo retrocessi nonostante un clima già abbastanza teso… dovevamo fare punti ma non ci riuscivamo. Perdemmo il primo spareggio, a Córdoba, e rimanemmo tre giorni nell’Hindú Club. Anche Daniel Passarella (il presidente di allora) dormì con noi e parlava tutto il tempo con Jota Jota López. C’era molta ansia ma, nonostante il risultato dell’andata, eravamo convinti di ribaltarlo. Quel giorno ero in panchina», racconta.
La retrocessione finì per materializzarsi con il marchio della sconfitta nella rivincita contro il Belgrano, anche se il River già si esprimeva attraverso un vocabolario da racconto poliziesco da un po’ di tempo a quella parte, tra le presidenze di José María Aguilar, fino a dicembre 2009, e del suo successore, Passarella: lavori pagati a prezzi maggiorati, vendita di giovani calciatori a imprese esterne, barra bravas a stipendio, trattamenti di favore verso imprenditori sospetti, pagamento di commissioni maggiorate rispetto agli standard di allora, denunce di riciclaggio, cattive gestioni, giocatori che dicevano di non guadagnare quanto firmato, appalti concessi senza gare e bandi, passivi astronomici, debiti bancari, assegni respinti, imprese fantasma, indirizzi mail non funzionanti e affari poco decorosi, come lo scambio tra percentuali di calciatori in cambio di barattoli di vernice per ristrutturare il Monumental.
Sfiancato da questi veleni endogeni, il River iniziò ad acquistare calciatori di categorie “B” e “C” attraverso trasferimenti che risultavano più convenienti per gli intermediari che per il club. Non li troviamo nella foto finale, ma nelle prime due stagioni delle tre in cui la retrocessione prese forma furono diversi i cognomi che ci succedettero e con cui identificare l’inizio della caduta: Miguel Paniagua, Mariano Barbosa, Robert Flores, Omar Merlo, Gustavo Canales, Santiago Salcedo e Cristian Fabbiani, la consacrazione di un malinteso per una tifoseria in astinenza di idoli, reali o inventati.
Se il progressismo di Aguilar fu un cammino verso il disastro – la sua presidenza terminò con 56 punti in 55 partite –, al governo di Passarella rimanevano 59 giornate per invertire la mala rotta: avrebbe ottenuto 85 punti e con solo due in più avrebbe evitato gli spareggi, il momento in cui il Belgrano finì per affondarlo. Dei sei tecnici protagonisti del processo di discesa, JJ López (il comandante finale) allenò per 25 partite e fu, paradossalmente, quello con la percentuale migliore di punti: 1,56. A seguire Ángel Cappa, con 1,50 in 18 incontri. I primi quattro allenatori, scelti da Aguilar e dal suo braccio destro, il polemico segretario Mario Israel, avevano ipotecato la squadra con percentuali da spareggio e da retrocessione diretta. Néstor Gorosito, in 26 partite, ottenne una percentuale pari a 1,23. Leonardo Astrada, anche lui in 26 match, totalizzò 1,11. Gabriel Rodríguez, supplente sulla panchina per cinque volte, arrivò a 0,80. E Diego Simeone, in 14 gare, fu il peggiore, con 0,71.
Ma visto che in ogni tragedia vi è anche una commedia, la squadra rilasciava frasi esilaranti mentre era in caduta libera. «Il River è Aruba», dichiarò Aguilar nel tentativo di dissimulare la sua gestione già compromessa. Più attento alle sue vicende personali che a quelle del River, Passarella ne aggiunse una: «Non fatevela sotto». Era convinto che, oltre a vincere nella classifica del “promedio”, sarebbe uscito vincitore nel suo scontro con Julio Grondona. Alle sconfitte sul terreno di gioco il River univa quelle fuori dal campo, altrettanto dannose, come quando Passarella, arrabbiato per un arbitraggio sfavorevole in un match contro il Boca Juniors, chiese al presidente dell’AFA di fare un passo di lato. Grondona si alzò e, esaudendo alla lettera la richiesta, fece un passo di lato. «Adesso cosa vuoi di più?», disse prendendolo in giro.
L’ecosistema del River finì per decomporsi nelle ultime giornate: in ogni partita cadeva una pioggia di meteoriti. L’insostenibile pressione di giocare contro la storia, gli attaccanti incapaci di buttarla dentro, errori non forzati del portiere Juan Pablo Carrizo, il fisico al limite di Matías Almeyda con i suoi 37 anni, una squadra incapace di vincere nelle ultime nove partite – sarebbe bastato un successo per salvarsi –, un Belgrano superiore all’andata, gli occhi vitrei di Jota Jota, l’ingresso di barra bravas incappucciati sul terreno di gioco, el Tano Pasman e le sue urla “Siamo in Serie B”, la profetica telefonata di Grondona al presidente del Belgrano («Sarete voi a cambiare la storia»), Carlos Arano messo a centrocampo, lo sterile gol di Mariano Pavone al Monumental, il rigore su Leandro Caruso non fischiato da un arbitro funzionale all’augurio di Grondona (Sergio Pezzotta), la pressione della barra brava sull’arbitro negli spogliatoi tra primo e secondo tempo, il pareggio di Guillermo Farré simile a una pugnalata, il calcio di rigore fallito da Pavone, i primi lanci di pezzi di legno dagli spalti verso il terreno di gioco, la sospensione della partita, gli idranti dei pompieri. E, in chiusura, il dolore che colpiva i giovani, i vecchi, i proprietari terrieri, i cartoneros, i giudici, i ladroni, l’immagine crepuscolare del Monumental distrutto e la tribuna superiore fumante, il dicembre del 2001, la sfida, la B.
«Subito passammo in vantaggio, lo stadio se ne veniva giù e pensavamo che l’incubo fosse alle nostre spalle, ma arrivò il mancato rigore su Caruso e rimanemmo fermi», riprende il discorso Gallucci Otero, che quel pomeriggio portava la camiseta numero 41 e in quelle foto e in quei video compare a metà campo piangendo insieme ad altri giocatori. «Dopo il fischio finale, rimanemmo venti minuti nel cerchio centrale e uscimmo scortati. Dello spogliatoio ricordo il silenzio. Rimanemmo muti fino a quando non entrò Passarella che disse che ci avrebbe sostenuto qualunque cosa fosse accaduta».
Vincere nella sconfitta
Conclusasi una fiaba lunga 110 anni, erano giorni in cui il River e il resto del mondo del calcio argentino sposavano teorie apocalittiche, che non lasciavano scampo: dalla Serie B non si torna più, un grammo di oro in un chilo di escrementi non cambia nulla ma un grammo di escrementi in un chilo di oro rovina il tutto. Ma il River avrebbe poi scoperto che la paura di fronte al fallimento sarebbe stata più distruttiva del fallimento in sé: come se il sottosuolo liberasse sollievo, il club fece un movimento di judo e finì con il trionfare nella sconfitta.
Fedeli nella disgrazia, e felici nell’infelicità, migliaia di soci liberarono anticorpi e si unirono al club qualche mese dopo la retrocessione: se il club veniva a mancare, il sentimento si moltiplicava. Nell’anno più strano ma più rivendicativo della tifoseria del River, ogni partita in B divenne un misto di agonia, esorcismo e purificazione: l’avventura del ritorno era anche quella di tornare ad esistere. Nel mezzo della tempesta, tra la resistenza, la riaffermazione e la speranza, passarono rivali dai nomi strani (Sportivo Desamparados), stadi dalle tribune basse, viaggi a Jujuy e in Patagonia ma anche carovane lungo la Ruta n. 3 fino allo stadio dell’Almirante Brown, carnefici che strappavano pareggi in partite stregate (Deportivo Merlo, Brown de Puerto Madryn), comici simbolismi (il River perse un sabato contro il Boca Unidos e il giorno dopo il Boca si laureò campione) e, finalmente, il ritorno in Prima Divisione, il 23 luglio dell’anno successivo alla retrocessione. Al centro della foto rimasero Almeyda, David Trezeguet, Fernando Cavenaghi e Alejandro Domínguez ed inoltre – o soprattutto – c’erano Jonatan Maidana e Leonardo Ponzio, gli uomini che avevano personificato la metamorfosi.
Gallucci Otero già non faceva più parte di quella squadra. Nel periodo di preparazione tra la Primera e la B Nacional, tuttavia, era stato il centrocampista centrale titolare nelle amichevoli contro Alvarado e Kimberley, a Mar del Plata, e Defensores de Belgrano e Nacional de Uruguay, a Buenos Aires. «Almeyda (già nelle vesti di allenatore) mi portò in ritiro e iniziai a giocare ma successe qualcosa di strano con Passarella e il mio agente e mi relegarono fra le riserve – dice –. Una delle partite che avevo giocato nella squadra A, prima dell’inizio del torneo, fu un’amichevole contro il Nacional. Pareggiammo tre a tre e ricordo come giocarono bene gli uruguaiani».
Già con Ramón Díaz in panchina e sotto la presidenza di Rodolfo D’Onofrio, il River si consacrò campione del torneo Final 2014 e la settimana successivo vinse la Copa Campeonato, passaporto per la Sudamericana. Il debutto internazionale del ciclo Gallardo, già mister del River, incontrò nuovamente Gallucci Otero nel suo ruolo di testimone privilegiato, anche se seduto in panchina, allora però come giocatore del Godoy Cruz. L’altra differenza rispetto al “26J” [26 giugno, N.d.T] fu ancora più sostanziale: non si trattava del finale di un ciclo putrefatto ma dell’inizio di un ciclo mistico.
Il River vinse 1-0 a Mendoza e Gallardo iniziò il cammino verso il primo dei suoi dodici titoli, quello nella Sudamericana (2014), due Libertadores (2015 e 2018), tre Recopas (2015, 2016 e 2019), una Suruga (2015), tre Copas Argentinas (2016, 2017 e 2019) e due Supercopas Argentinas (2017, giocata nel 2018, e 2019, vinta nel 2021). In tutta questa successione di avvenimenti entrarono cinque incroci consecutivi contro il Boca che videro anche due finali, una delle quali, quella che iniziò alla Bombonera e finì a Madrid, fu l’oggetto più simile a una cometa di Halley nel fútbol.
Casualmente o meno («le cose accadono per qualche motivo», dice il giocatore), il penultimo titolo del River, la Copa Argentina 2019, ebbe ancora Gallucci Otero seduto su di una panchina, stavolta come giocatore del Central Córdoba de Santiago del Estero. «Mi è rimasta come una spina conficcata il fatto di non aver giocato più a lungo con il River – racconta –. Io ero, e sono, un gran tifoso, lo era da bambino, per via della mia famiglia. Ci fu un momento in cui mi arrabbiai ma capii che non doveva essere con il River ma con la gente che era nel club in quel momento. Tutte le gioie che ci aveva dato la squadra in quei tempi ci aiutarono a compensare il dolore provocato da quella spina. Sono stato tredici anni nel River, mi sono formato lì, e nella finale con il Central Córdoba incrociai gente della mia epoca. Ponzio, i dirigenti e i magazzinieri».
Nell’epoca di moderni idoli, come Ponzio e Maidana, ma anche come Enzo Pérez, Franco Armani, Gonzalo Pity Martínez, Juanfer Quintero e Lucas Pratto (senza dimenticare le bandiere che avevano vinto i primi titoli del ciclo Gallardo, come Marcelo Barovero, Carlos Sánchez, Gabriel Mercado, Leonardo Pisculichi o Lucas Alario), arrivò il 9 dicembre del 2018. In una immagine che non colse la trasmissione televisiva, pochi minuti dopo il termine della finale contro il Boca, una ventina di tifosi del River iniziarono a gridare dalle tribune del Santiago Bernabéu, a Madrid, «Iooo sono della B, iooo sono della B», un modo di dire «Sì, siamo stati in Serie B…», la punta più alta dell’orgoglio delle proprie cicatrici. Il soprannome di gallina, nel 1966, nacque come derisione delle tifoserie rivali dopo che il River perse una incredibile finale della Libertadores, ma con il tempo si trasformò in codice di onore. Magari un giorno la tifoseria tornerà ad intonare quella canzone che un gruppo improvvisò a Madrid.
Intanto, come scrisse Jorge Luis Borges, «ci sono sconfitte che hanno più dignità di una vittoria». O come dice Gallucci Otero, sposando questa teoria del 26 giugno 2011 come il primo passo del 9 dicembre 2018: «Chissà se doveva esserci la retrocessione per farci vincere tutto quello che abbiamo vinto. Bisognava iniziare da zero».